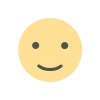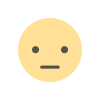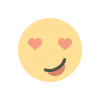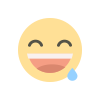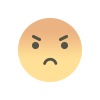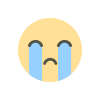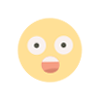Fedi globali, guerre locali: ai Med Dialogues il paradosso del sacro in politica

In una città che è da secoli crocevia di popoli e fedi, Napoli, si è svolta nei giorni scorsi l’undicesima edizione dei “Med Dialogues”, l’iniziativa annuale di diplomazia pubblica promossa dalla Farnesina in collaborazione con l’Istituto per gli studi di politica internazionale (Ispi). Non si è parlato solo di geopolitica, sicurezza o rotte energetiche, ma la due giorni di lavori al Palazzo Reale ha ospitato anche un dibattito per decifrare le tensioni del nostro tempo, durante il quale si è discusso di una forza ben più antica e potente che è tornata a plasmare i conflitti e le società: la religione. Proprio su questo tema, un interrogativo posto dal moderatore del panel intitolato “Il sacro e il politico: religione e spazio pubblico nel Mediterraneo”, lo storico del cristianesimo Alberto Melloni, ha dato il là a una riflessione profonda, riecheggiando un’analisi che risale ormai a diversi decenni fa: siamo ancora nel pieno della “vendetta di Dio”? Quella spinta, teorizzata in modo estremamente evocativo dallo studioso francese Gilles Kepel e innescata nel 1978 dall’elezione al soglio pontificio di Giovanni Paolo II e dalla rivoluzione khomeinista in Iran, che sfidava le grandi narrative laiche della modernità, oggi si manifesta infatti in forme nuove e globali, mettendo sempre più in discussione i confini tra sfera sacra e potere politico. L’analisi che emerge è quella di un mondo percorso da un doppio movimento paradossale: da un lato, l’affermazione di agende politico-religiose globalmente simili; dall’altro, una polverizzazione delle credenze a livello locale. Una dinamica che alimenta tensioni profonde, specialmente sulle sponde del Mediterraneo e in Africa, dove la ricerca di una coesistenza rispettosa si scontra con la tentazione della strumentalizzazione. A tracciare le coordinate di questo complesso scenario è stata la sociologa delle religioni Kristina Stoeckl, che insegna alla Luiss Guido Carli di Roma. Nel suo intervento ha spiegato come, a livello globale, si stiano affermando “progetti politico-religiosi curiosamente omogenei e convergenti”. Movimenti di estrema destra in India, partiti cristiani conservatori in Europa, la galassia Maga (Make America Great Again) negli Stati Uniti o certe correnti dell’Islam politico, pur partendo da tradizioni diverse, condividono un’agenda sorprendentemente simile: un richiamo a “conservatorismo, gerarchia, ordine e spesso patriarcato”. Questi movimenti, spiega Stoeckl, cercano una “legittimazione religiosa” per riempire un vuoto di valori lasciato dal declino delle grandi ideologie del Novecento. Il risultato è la creazione di pericolose “spiritualità politiche”, che per loro natura sono esclusive. “Diventano violente nei confronti dell’altro – avverte la sociologa – ma anche verso chi, all’interno della stessa comunità, è percepito come diverso”. La spinta all’omologazione si scontra però con la realtà dei fatti. A livello locale, infatti, il processo è inverso: una crescente “frammentazione delle credenze” e delle visioni del mondo. La secolarizzazione, le migrazioni e l’individualismo spirituale hanno eroso quella che il sociologo Émile Durkheim chiamava “solidarietà sociale”, basata su valori morali condivisi. Si crea così una tensione esplosiva: leader che pretendono di parlare a nome di una fede monolitica si rivolgono a società che, in realtà, sono irrimediabilmente plurali. Questa analisi trova riscontro diretto in Nord Africa. Pensiamo al ruolo del presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, che si appoggia alla storica istituzione sunnita della moschea di Al-Azhar per proiettare un’immagine di ordine e tradizione, mentre reprime con durezza l’Islam politico incarnato dai Fratelli Musulmani. O alle continue tensioni che attraversano la Tunisia post-rivoluzionaria, perennemente in bilico nel definire il ruolo dell’Islam in una cornice statale che aspira a rimanere laica e democratica.
Qual è la tua reazione a questa notizia?